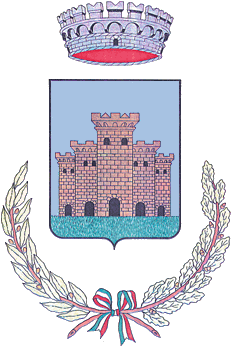|
Archivio storico de L’Eco di Roccasecca
Esattamente 10 anni fa, per l’edizione n. 10, Anno 2, de L’Eco di Roccasecca, pubblicavamo un articolo dedicato alle tradizioni folkloristiche della città di Arce. La fonte è un testo del 1957, giusto cinquanta anni fa. Gli appassionati di argomenti “culturali ciociari” che all’epoca non ebbero modo di leggere queste pagine avranno sicuramente piacere di poterle scoprire oggi. Buona ri-lettura a tutti!
Lo stemma di Arce
Continua la nostra instancabile opera di ricerca di testi e documenti della Biblioteca dell’Eco, da cui estrapolare argomenti di indubbio interesse per i nostri lettori. Questa volta, dal volume “Arce” scritto dal professor Mario Corsetti e pubblicato nel luglio del 1957, abbiamo tratto il capitolo intitolato “ARCE: NOTE FOLKLORISTICHE”, che di seguito vi proponiamo. L’argomento trattato ci sembra particolarmente interessante, soprattutto nella prima parte dedicata al dialetto, molto simile, sia pure con diverse sfumature, a quello roccaseccano. Le tradizioni caratterizzano i popoli attraverso i secoli e vicende, e quando corrispondono ad un ideale di bellezza sono maggiormente belle e care. La popolazione arcese è buona, laboriosa, generosa, amante della famiglia e della giustizia, entusiasta del bello. Il nostro dialetto è un miscuglio di lingua osca, greca, latina con accenti a volte romano a volte napoletano. Tanto per citare alcuni vocaboli: “so ito a terra” per dire “sono andato giù, in basso”; “so ito 'ncima” per dire “sono andato su”; “te si arrajate”, per dire “come sei ingordo o come sei affamato!”; “damme no nu ccone” per “dammene un poco”; “statte loco” per “resta lì”. Così pure i dimostrativi questo e quello si esprimono con “chistu”, “stu”, “chissu”; questi e questa, codesti e codesta, quelli e quella si mutano in “chisto” e ”chesta”, “chisso” e “chessa”, “chiglio” e “chella”. L'articolo il, lo muta in “gliu” come per es. “gliu sole”, “gliu spago”. Lui e lei mutano in “isso” e “essa”. Il padre si chiamava “tata” , ed il nonno “tatone”. Si usava e si usa ancora di dare dello “zio” o “zia” ( accorciato a “zì” ) alle persone anziane come in segno di rispetto.
Ciociara orante Prima le nostre donne portavano “gliu zinale”, cioè il grembiule, di solito nero ed in testa la tovaglia con pizzi; questa era un fazzoletto bianco inamidato opportunamente piegato sì da coprire la testa scendendo per tre lati fino all'altezza delle spalle, lasciando, naturalmente, scoperto il viso che così incorniciato acquistava luminosità e pregio, specie se spiccavano trecce o chiome di capelli neri (vedi quadro “ciociara orante”). Oggi donne in costume non se ne vedono più: solo qualche vecchietta ultraottantenne fa da modello a qualcuno che volesse ancora avere l`idea del costume. Degli oggetti comuni hanno conservato la forma antica la “cannata” di creta, la conca di rame, treppiedi, candelieri che sono tutti a forma romana-etrusca, l'arca a coperchio convesso per riporvi pane od altri utensili da cucina.
Zampognari con le caratteristiche ciocie
La ”ciocia” (da cui “ciociaria”) è una forma di calzare di origine romana, costituito da una doppia suola con la punta alzata in avanti e mantenuta aderente al piede da stringhe di cuoio girate o “abbudinate”, ben 13 volte attorno alla gamba la quale è rivestita fino al ginocchio da una fascia o pezzuola bianca. La ciocia è anche in uso in altre parti dell'Italia centrale, in Calabria e nelle regioni montuose della Balcania. “La leggenda che la Ciociaria sia una regione arretrata con una popolazione primitivamente agreste, quasi incolta, in una solitudine secolare, è nata dalla colpevole presunzione e prevenzione di voler giudicare la gente... dai piedi invece che dalla testa. Infatti, poiché il nome di Ciociaria vuol significare la terra abitata da un popolo forte e generoso, semplice e lavoratore, dai calzari di cuoio a guisa di sandali legati da stringhe pure di cuoio avvolte, a spirale, al collo del piede, chiamati “ciocie”, molti han dato la nomèa dispregiativa al popolo non avendo presente, fra l'altro, che le ciocie sono simili alle calzature militari - e da esse probabilmente derivano - degli antichi romani, che le diffusero e le fecero usare ovunque piantarono le loro tende vittoriose e portarono i loro costumi di vita”. (Avv. Armando Riccardi in Lazio d'oro , Ed. Nostra Italia Roma, 1956). Come usanze ricorderemo le pizzelle e l'immancabile piatto di vermicelli al “cenone” della vigilia di Natale; la “cicerchiata” a Carnevale; i falò da accendere alla vigilia di S. Giuseppe ed i lumini da mettere fuori alla finestra la sera della vigilia di Tutti i Santi (1 Novembre) perchè i morti ,”passando per andare in cielo si accertino che nella loro ex terrena dimora c'è ancora un lume di fede”. Quanta poesia e fede in questa tradizione! Un'usanza, forse unica nella zona, è quella di “portare al Santo” i neonati il cui parto è stato difficile. Nei cinque o dieci giorni dalla nascita, una fida incaricata si reca in chiesa col neonato e lo pone o sull'altare dedicato a quel Santo cui si è devoti o su un altro. La portatrice si confonde cogli altri fedeli ed osserva. Chi dei presenti, avendo notato il bambino, vuol battezzarlo, deve avvicinarsi e prenderlo in braccio: “lo raccoglie”. A questo punto si fa avanti la portatrice e di solito anche il padre e si procede subito al battesimo omettendo qualsiasi pompa e solennità. Tutto il significato sta nel fatto che da parte della madre v'è la rinunzia ad ogni festa esteriore a ricordo del difficile parto sì che il padrino, sia esso povero o ricco, viene così designato dal caso quasi per ispirazione del Santo cui è stato “offerto”. Una bella usanza, piena di misticismo e di pietà cristiana, è quella di digiunare il 5 Maggio. Cosa ricorra in questo giorno non ci è dato sapere: nemmeno i nostri padri ce l'hanno saputo dire. In onore della Madonna tutta la popolazione digiuna assaggiando a mezzogiorno ed all'Ave Maria solo pane e bevendo acqua. Si racconta che circa 50 anni fa alcuni amici buontemponi, ma sopratutto indifferenti alla fede del popolo, vollero schernirsi di tale pietosa e devota usanza e si riunirono nei sotterranei uso cantina di un fabbricato del Sig. Quattrucci Giovan Battista - ora carceri - a Castello e lì fecero preparare diverse portate a base di maccheroni e carne di diverse specie. Nel mettersi a tavola, a ciel sereno, un fulmine serpeggiò per la tavola imbandita rompendo i piatti, lasciando però incolumi i convitati. Caratteristici sono gli improvvisati suonatori e cantori nel tempo di “Passione”. Nelle due domeniche precedenti la Pasqua, cioè in quella di Passione e delle Palme, gruppi di due, tre ed anche quattro persone, di solito giovani, al suono di una fisarmonica o anche senza, con un ramo di ulivo in mano (al quale sono appesi nastri e figure di santi) girano casa per casa cantando “La Passione”. Cantano versi popolari - che di solito non si capiscono - che ricordano le fasi della Passione di Nostro Signore. In compenso hanno danaro od uova. La festa dell'Immacolata (8 Dicembre) e di Natale, poi, è preceduta da “novene”, a suon di zampogne o cornamuse e ciaramelle (i latini la chiamavano “tibia utricularis”). Pastori della Val di Comino (Villa Latina, Atina, Settefrati) con tanto di “ciocie”, dopo essersi prenotati alcuni giorni prima lasciando come pegno una figura della Madonna o del Presepe attaccata ad ogni porta e dando come omaggio un cucchiaio di legno, vengono a suonare la novena. Sicché dall'alba al tramonto girano casa per casa suonando e cantando motivi pastorali. Il ciaramellista alterna il suono al canto di strofe: chiudono con la pastorale ”Tu scendi dalle stelle o Re del cielo...”. A capodanno altri suoni e canti. Ora sono più o meno gli stessi gruppi della “Passione” che nel canto inneggiano alle fortune della famiglia e della casa per cui suonano nominando anche i componenti. Per es.: “I' voglio che l'anvidia non ce sia a 'ntonio pure la porzione sia. I' voglio che l'anvidia non ce possa a Maria la chiù parte grossa”.
Concludiamo con alcune note sul Santo di Arce, Sant’Eleuterio. Si narra che quando egli giunse in Arce, di ritorno dal pellegrinaggio in Terra Santa, molto affamato chiese ristoro ed alloggio alla taverna presso la torre medievale, , ma l’oste non solo gli rifiutò ospitalità, ma gli aizzò contro due cani rabbiosi che, invece di azzannare il pellegrino, toccati dalla “chiave di Sant’Eleuterio”, si ammansirono subito e gli leccarono le ferite. Ancora oggi, memori di questa storia, si consiglia ironicamente di andare a baciare la chiave di Sant’Eleuterio alle persone che hanno molta fame o rabbia. Tra i miracoli di Sant’Eleuterio, si racconta che, nell’ultima guerra mondiale, i tedeschi tentarono invano di adibire la chiesa del Santo a stalla. I cavalli, spinti ad entrare, si bloccarono davanti all’ingresso.
|